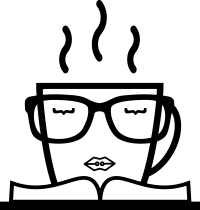Scrivere di L’inconfondibile tristezza della torta al limone di Aimee Bender, edito da Minimum fax, è complicato. Non si sa bene come iniziare. Come mettere in sequenza i pensieri, tentare di scrivere con lucidità e chiarezza quello che rimane dopo la lettura. Perché parlare di un romanzo che fa parte del “realismo magico”, se quello che si è letto è di inusuale bellezza, è una sfida.
Iniziando della trama, il romanzo potrebbe risultare drasticamente impoverito. Iniziando invece dalle tematiche che si intravedono tra i personaggi e gli eventi, il libro perderebbe il suo fascino. Perché ne L’inconfondibile tristezza della torta al limone sono le immagini, i sensi, gli odori, le mancanze, il non detto, il vuoto, la coralità degli oggetti comuni, delle emozioni, delle consapevolezze a dettare la narrazione. E questo romanzo impone – e merita – di essere raccontato rispettando tutto questo, e partendo da qui.
Una bambina di nove anni assaggia una torta fatta dalla mamma. Ne stacca un pezzetto con le dita quando è ancora calda. Un piccolo pezzo di dolcezza tutto per sé, prima di chiunque altro. Profuma di limoni, il pan di spagna è dorato e soffice. E in bocca tutte quelle sensazioni ci sono, la torta è morbida, la freschezza del limone e la dolcezza del burro si espandono nel palato, lo zucchero imbrunito rilascia una nota leggermente amara, eppure. Eppure sembra che ci sia qualcos’altro, come se la bontà degli ingredienti fosse una coltre sopra ad altri sapori che affiorano lentamente. Piccolezza, rattrappimento. Vuoto. E sua madre. Rose sente indistintamente che sono le mani di sua madre che hanno impresso all’impasto quel buco, quel senso di inquietudine.
E l’unica – ma di una maturità sconvolgente a pensarci bene – cosa che riesce a fare è accucciarsi per terra, in quel caldo pomeriggio del west coast, e chiedere a sua madre: stai bene?
Rose ha nove anni e scopre di assaporare in quello che mangia le emozioni di chi ha preparato il cibo. E la scoperta è la più amara di tutte se le dita di una madre sorridente trasmettono invece tristezza, nonostante la dolcezza della torta. Rose ha nove anni e un peso sulle spalle che le butta addosso una maturità, una consapevolezza della profondità delle emozioni umane, indicibile. Cosa c’è di peggio che sentire tutti i giorni, nel pasto della mensa scolastica, la frustrazione? E nei biscotti della pasticceria del quartiere rabbia?
Alcuni giorni sembra più facile, basta che in mensa si scelga sempre il piatto cucinato dall’ultima cuoca in fondo, il suo cibo è meno annoiato. Poi ci sono i distributori automatici e i cibi industriali, la sua salvezza. Soprattutto quegli snack che sono preparati solo dalle macchine, niente uomini alla catena di montaggio, niente emozioni. Altri giorni invece è un peso incredibile, tanto da volersi strappare la bocca dal viso, eliminare quel veicolo di grumi di dolore e di insoddisfazione. E Aimee Bender riesce a fartelo sentire il panico, l’insofferenza di Rose che tenta di sradicare la sua bocca, la difficoltà di gestire tutte quelle informazioni. Già, perché all’inizio il cibo di sua madre sa di inquietudine, ma poi di senso di colpa e di adulterio.
Rose vorrebbe mettersi al riparo dalle emozioni umane, dal dover sentire tutto quel dolore. Vorrebbe trovare un modo per estraniarsi, per ignorare, per allontanarsi da questo bombardamento di sentimenti, anche per poco. Magari come sta facendo Joseph, suo fratello. Chiuso per ore nella sua stanza, fra quegli oggetti e quelle mura, come se il mondo fosse tutto lì, solitario e silenzioso. Così solitario che spesso scompare nel nulla, senza far rumore, senza che nessuno se ne accorga anche se un vago senso di lui rimane ancorato nella sua stanza, stranamente.
Aimee Bender riesce a tratteggiare con una dolcezza estrema i contorni di un pezzo di vita di una famiglia americana che nasconde, come tutte le famiglie, segreti e desideri assopiti. E lo fa mettendo al centro della spirale narrativa una bambina, che tra le pagine diventa una giovane donna, che combatte con quello che le accade per trovare un modo per esistere, per resistere.
Perché in questo romanzo il cibo e quello che succede a Rose è solo un particolare misterioso. Il vero nucleo della narrazione è il tentativo di superare il disaddattamento, riuscire a costruirsi un’armatura che permetta di affrontare la vita. Ognuno a modo suo, in base al bagaglio che ci si porta dietro. Che sia colmo di strani attitudini o ordinarie qualità, poco importa.
Rose, che altro non ha che una valigia un po’ diversa da quelle di tutti gli altri, non può fare altro che mettersi in macchina e con i primi soldi guadagnati provare ogni ristorante di Los Angeles – una città solo abbozzata dalla penna della Bender – alla ricerca di quel cuoco che nei suoi piatti trasmetta solo l’amore per il cibo e poco altro di sé. Joseph invece, custode di un altro segreto, troverà un’altra strada per poter sopravvivere e Rose sarà l’unica a saperlo, e a capirlo.
Il realismo magico di cui spesso si parla come misto tra favola e realtà, nella Bender è qualcosa di diverso. Perché ciò che c’è di fiabesco, se così si può chiamare, non è altro che un correlativo oggettivo della sofferenza di dover fare i conti con qualcosa che non si vorrebbe avere, conoscere, sapere, vivere. È un altro modo di raccontare il disagio di doversi costruire un’esistenza. Perché nell’immagine di una bambina che si vuole strappare via la bocca c’è tanta realtà quanta ne troviamo nel dolore di chiunque vorrebbe sradicare il proprio cuore dal petto per non sentire più certi sentimenti. Perché il racconto di Joseph che decide di non tornare più indietro ha tutto il carico emotivo di un suicidio reale. Quella sedia pieghevole in cui è scomparso ha in sé tutto il dolore e la sofferenza muta di una tomba e il lettore, nonostante non sia davanti a un evento di cui può fare esperienza, riesce a cogliere perfettamente tutta l’atroce concretezza di quell’addio al mondo.
In L’inconfondibile tristezza della torta al limone la Bender riesce così a mantenere quella promessa tacita che ogni scrittore fa con i suoi lettori: la verosimiglianza. Anche se si parla di zuppe che sanno rabbia o di sedie che contengono fratelli. E lo fa scrivendo magnificamente, riuscendo a dipingere con le parole un mondo a noi sconosciuto e che pure riconosciamo come nostro.