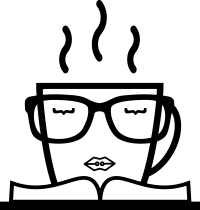Un’opera intelligente e delicata, attuale e sospesa, solida e rarefatta: Bar Atlantic, libro magistralmente scritto dallo studioso di lingua ebraica Bruno Osimo e pubblicato dalla casa editrice Marcos y Marcos.
Il cuore del libro è Adàm, professore immigrato ormai da anni in Italia, dall’esistenza frammentata in sei diverse vite, una per ogni giorno lavorativo. Più la sesta, quella del fine settimana e del riposo.
Adàm lavora il lunedì ad Alessandria, il martedì a Bergamo, il mercoledì a Pavia, il giovedì a Treviso, il venerdì a Verona. Ogni giorno prende un treno con una destinazione diversa, ma la partenza è sempre la stessa, Milano. Qui Adàm torna a casa dal lavoro, passa a far la spesa, cucina con passione e precisione. Ma ogni città è qualcosa di più di un luogo in cui fermarsi per qualche ora. Perché Milano vuol dire anche Ada, sua moglie. Alessandria ha il sapore dei preliminari con Paola, Bergamo ha i contorni del naso di Monica, Pavia è Teresa, Treviso è Fernanda, Verona è Sasha.
Adàm è un precario del lavoro, dell’amore, dei luoghi. In una esistenza che si snoda in un nord Italia ripetitivo, Adàm riesce a trovare il suo equilibrio solo parcellizzando le sue emozioni tanto quanto il suo insegnamento, tanto quanto il suo migrare da una città all’altra.
Eppure, pur essendo i temi affrontati estremamente seri e attuali, la bravura e la grandezza di Osimo sta nel non renderli vessilli posticci di una realtà difficile, ma di cucirli addosso ad un’anima, quella di Adàm. E se si reifica un concetto e lo si rende umano allora si riesce veramente a parlare di cosa può essere l’esistenza, anche attraverso l’escamotage della narrazione.
Con Adàm, Osimo riesce in un’impresa difficile: il lettore si ritrova spettatore di una vita di cui è partecipe di bellezza, di piccole cose. Cadono le barriere del giudizio, scompare il giusto e lo sbagliato. Rimane un uomo, dall’esistenza appesa a tanti fili, in cui sono le piccole cose di cui è profondamente innamorato (nel senso più alto e ampio del termine) a cementare l’io, pur in assenza di un baricentro vero e proprio.
Perché Adàm ama e venera sua moglie, ma allo stesso tempo ama anche la voce di Monica e l’amore fatto nel monolocale di Sasha, ama i granelli di zucchero grezzo che si sentono distintamente nel morsicare un biscotto, ama un pezzo di formaggio mangiato in treno, la musica che esce dalle cuffie dell’ipod, le poesie che scrive seduto al bar e la corsa del week end in riviera, guardando il mare di Levanto.
Accanto a tutto questo Osimo ci parla della lingua ebraica, attraverso gli insegnamenti del protagonista. Della complessità di una lingua antica e di come sia difficile coglierne il senso profondo per quegli studenti contemporanei che siedono nelle sue aule. Come spiegare il duale, per esempio? Come far capire che oltre al singolo e alla molteplicità è esistito un tempo in cui c’era anche il senso del doppio, del due?
L’Adàm di Osimo appartiene proprio a all’universo del duale, lontano e quasi inspiegabile ma irrimediabilmente vero e umano.
Un’opera riuscita, leggera e profonda al tempo stesso, in cui i difetti (come le note a piè pagina che con il loro umorismo rompono la poetica della narrazione) passano assolutamente in secondo piano.